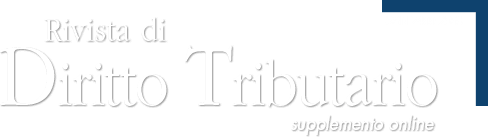Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.